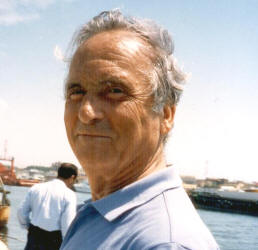
Silvano Rizza
Chi era Silvano Rizza, pochi aggettivi, da chi lo ha conosciuto e stimato, come collega, come maestro e come amico. Il ricordo di Vittorio Roidi, che con Rizza ha lavorato al Messaggero e collaborato per la formazione dei giovani giornalisti alla Scuola di Urbino
- di Vittorio Roidi Ci vuole una premessa.
Conobbi Silvano Rizza nel 1986, quando dimessomi dalla Rai ero tornato al Messaggero, chiamato da Vittorio Emiliani a fare il capocronista. E mi ero seduto sulla sedia che per otto anni era stata di Silvano, divenuto condirettore. Poi i tanti anni all’Ifg di Urbino. Rizza l’aveva fondata insieme con Enrico Mascilli Migliorini, il preside di Sociologia e aveva creato il giornale, il Ducato (quello formato grande, in bianco e nero), con Pino Geraci. Scomparso improvvisamente Pino, mi aveva chiamato accanto a sé.
Com’era Rizza? Proverò a dirlo con poche parole – per l’esattezza otto – se mi riesce senza retorica, che lui odiava, così come detestava le cerimonie, i funerali, i formalismi e tutto ciò che non era pratico, concreto, utile. Al mestiere naturalmente.
Perché la prima parola è giornalista. Nessuno ho conosciuto come lui. Rizza il giornale lo…incarnava. Dal primo mattino fino mezzanotte, quando ancora leggeva gli altri quotidiani che gli erano rimasti sul tavolo. Non si dedicava ad altro. Silvano, mi perdonino i figli, viveva per il giornale, gli dedicava ogni energia e ogni pensiero.
La seconda parola è libero. Non frequentava partiti politici (qualcuno gli appioppò il timbro radicale) e non si avvicinava mai al potere. Era indipendente fino a quando poteva. Sapeva che anche il compromesso era necessario, ma quando non lo sopportava semplicemente salutava e prendeva la porta.
La terza parola è bravo. Esperienza e tecnica gli consentivano di ribaltare un giornale in pochi minuti, di rifare menabò e titoli che altri avevano sbagliato. E cercava di interpretare le esigenze del lettore. Nessuna altra.
La quarta è capo. Perché sapeva decidere, organizzare il lavoro, prendersi le responsabilità, sempre senza interruzione, ché il quotidiano non consente pause, dalla mattina alla sera.
La quinta è cronista. I fatti, a lui interessavano quelli. L’avvenimento, i particolari, più che le opinioni di cui i giornali oggi sono pieni. Cronaca: un giornalismo asciutto, immediato, senza fronzoli, quello che aveva contribuito a inventare con Gaetano Baldacci e con la formidabile squadra del Giorno, a Milano, in un’epoca in cui i giornali italiani erano paludati, pesanti, illeggibili.
La sesta è testardo. Qui però bisogna intendersi perché in verità Rizza era sempre pronto a discutere. Anzi, alle otto di sera, bloccava il lavoro e diceva: “Fermi, parliamone, riflettiamo su cosa stiamo facendo e come”. Alla fine era difficile che cambiasse opinione, anche se lasciava parlare ed era disposto ad ascoltare.
Ecco perché la settima parola è democratico. Comandava, ma gli altri lo stimavano, perché con lui si esprimevano e imparavano. I giornali non possono essere democrazie assembleari. Hanno bisogno di qualcuno che decida, sul tamburo, in pochi istanti. E lui lo faceva. Però durante la riunione del mattino – pur essendo il più ruvido e severo – la discussione la accettava, perché sapeva che il confronto è indispensabile al buon giornalismo, anche se chi ha alzato la mano è l’ultimo dei praticanti.
L’ultima parola è insegnante. Lo ha fatto da capocronista, da condirettore (e direttore di Paese Sera). Ha continuato a farlo a Urbino, con incredibile passione, addestrando le centinaia di giovani che sono passati nelle aule e nel laboratorio della scuola. Pagine, testi, titoli e tante discussioni sull’etica del buon giornalismo. Ragazzi e ragazze che hanno imparato da lui e che, ne sono convinto, non possono averlo dimenticato, anche se ancora una volta ha deciso di andarsene.







