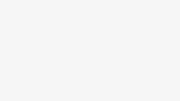di ELEONORA SERAFINO
URBINO – Libri ovunque, quadri, un camino in pietra non scalfito dal tempo, volte rinascimentali e pavimenti in cotto. Allo scrittore siciliano Leonardo Sciascia e allo scrittore fanese Valerio Volpini probabilmente la storica location di Palazzo Passionei Paciotti di Urbino, in cui il 24 maggio si è discusso del loro rapporto epistolare durato trentadue anni, sarebbe piaciuta molto.
La conferenza, intitolata “La parola come coscienza”, è stata organizzata dalla Fondazione Carlo e Marise Bo, in occasione della presentazione della ricca raccolta di lettere che i due letterati si sono scambiati dal 1952 al 1984, fatta da Tiziana Mattioli, docente e ricercatrice all’Università di Urbino Carlo Bo, sulla rivista internazionale di studi sciasciani Todomodo.
Rivista su cui hanno scritto dell’amicizia che legava Sciascia e Volpini anche il docente, filologo e critico letterario Massimo Raffaeli e il professore di Filosofia delle religioni all’Università di Urbino Piergiorgio Grassi, entrambi intervenuti, insieme alla professoressa Mattioli, al convegno.
“Abbiamo scelto di chiamare questo incontro ‘La parola come coscienza’ – spiega Tiziana Mattioli – perché ciò che legava questi due grandi uomini non era solo la passione per la letteratura e la scrittura, ma anche per l’impegno politico”.
Volpini, partigiano (partecipò giovanissimo alla Resistenza) e direttore de L’Osservatore Romano dal 1978 al 1984, dalle pagine del quotidiano della Santa sede, durante il sequestro di Aldo Moro, scrisse un corsivo anonimo di quindici righe favorevole alla trattativa con le Brigate Rosse per salvare la vita dello statista che la stampa di tutto il mondo attribuì alla penna del Papa. Sciascia, come ricorda Massimo Raffaeli, “ha una brevissima infatuazione comunista, infatti scriverà frasi come ‘non posso essere comunista, credo nel peccato originale’ o ‘non posso dirmi comunista, sono a sinistra del comunismo’”. E anche lui assume una posizione ben precisa nei confronti di Aldo Moro, che “non considera uno statista fino al marzo del ’78, quando viene lasciato solo e dice le parole della sua verità parziale”, conclude Raffaeli.
Le lettere raccolte da Tiziana Mattioli, dall’Associazione amici di Sciascia e da Giovanni Volpini, figlio dello scrittore, testimoniano un sodalizio, durato dal 1952 al 1984, tra “due intelligenze – racconta Mattioli – che sembrano così lontane nella visione della realtà ma che hanno trovato elementi di vicinanza e comunione”.
Sciascia laico, seppur con qualche cedimento negli ultimi anni di vita, Volpini cattolico, si sono confrontati in lettere definite dalla studiosa “brevi e pregnanti, scolpite e scattanti” sugli argomenti più disparati, trovando innumerevoli punti di contatto. Non a caso lo scrittore siciliano in uno dei suoi ultimi scritti mandati al giornalista fanese dice: “È curioso come tra noi, tu cattolico, io laico da sempre, ci sia stata unità di pensiero. Il fatto è che siamo cristiani nel senso siciliano della virile consapevolezza”. Lo Sciascia che si avvicina alla fine, provato dalla malattia, ma anche in altri momenti, vive vari dubbi e incertezze. Quando esce A ciascuno il suo, ricorda Piergiorgio Grassi, “parla a Volpini del suo romanzo come espressione di un momento di crisi: ‘il momento più cristiano che abbia finora conosciuto e tu da cristiano senza virgolette lo avevi certamente notato’”.
Le analisi e le recensioni che Volpini fa delle opere di Sciascia, e che gli manda tramite posta, diventano per quest’ultimo “uno specchio fondamentale”, spiega Mattioli.
Emblematica da questo punto di vista la lettera in cui, criticando una sua opera, Volpini gli scrive: “Ti sei perso nelle arsure della ragione, dimenticando il cuore”. E Sciascia, che avrebbe potuto reagire piccato, invece gli risponde facendogli capire che “questo giudizio – afferma Tiziana Mattioli – gli è più caro di ogni altro giudizio sia stato scritto o si scriverà”.
Il rapporto tra i due e di entrambi con la città ducale è suggellato anche da un altro nome importante, quello di Carlo Bo. Volpini, che come ricorda Massimo Raffaeli, “era uno studente di Carlo Bo”, “aveva raccolto – spiega Tiziana Mattioli – la sua lezione secondo cui ‘in ogni poesia c’è una violenta teologia’”, per scrivere, nel 1952, la sua Antologia della poesia religiosa, con prefazione di Pier Paolo Pasolini. Un’antologia, continua la studiosa , “scritta per ricostruire la poesia romanesca, ma che voleva essere una scommessa, perché composta da soli quattro autori che – e in questo ritorna il pensiero di Bo – non sono rigorosi cattolici”.
Il carteggio tra questi due grandi intellettuali del Novecento ha dell’incredibile se pensiamo che è durato trentadue anni e che in questi trentadue anni gli scrittori si sono visti un’unica volta. Una vicinanza, dunque, non fisica ma spirituale, rafforzata dalla “comune progettualità. Entrambi – spiega Tiziana Mattioli – tenevano all’essenza delle cose e all’etica del fare, del lavorare, dello spingersi in avanti. Una progettualità che intravediamo anche nella vita politica della nostra Italia”. Rileggendo le lettere, infatti, si può ricostruire uno spaccato del Belpaese: dall’alluvione di Grosseto, vissuta personalmente da Sciascia, ai riverberi del caso Moro, dalle discussioni con i partiti al fermento artistico e letterario di cui i due illustri amici di penna sono stati indiscussi protagonisti.